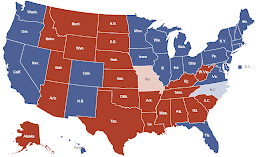mercoledì 30 gennaio 2008
McCain vs McCain
Video che raccoglie le più sorprendenti dichiarazioni contradditorie del candidato repubblicano alla presidenza.
domenica 27 gennaio 2008
venerdì 25 gennaio 2008
Fattore eleggibilita': un enigma americano
(da: CFP NEWS - Anno 4 Numero 112 – 25 gennaio 2008)
di Valentina Pasquali, Washington DC
La divisione tutta americana dell’elezione presidenziale in due tronconi, con le primarie di partito che aprono i giochi e le elezioni nazionali che li chiudono a quasi un anno di distanza, ha il pregio di portare alla luce la moltitudine di correnti di pensiero e di conflitti ideologici che esistono anche in questo paese, nonostante un sistema rigidamente bipartitico che limita e comprime il dibattito politico interno.
In questi giorni, i candidati democratici in corsa per la nomination del 2008 sono in Carolina del Sud, dove i membri del partito voteranno sabato 26 gennaio. I repubblicani, invece, stanno facendo campagna elettorale in Florida nell’attesa del voto del 29. La strada verso la Casa Bianca prosegue così rapidamente in direzione del Super Tuesday, il martedì 5 febbraio in cui ventiquattro stati dell’unione terranno le primarie contemporaneamente. E si sente nell’aria un desiderio crescente da parte degli elettori, ma soprattutto da parte dei media, di conoscere i nomi dei due candidati che si contenderanno la presidenza in novembre. Nello scambio sempre più intenso di pronostici si cominciano a delineare in maniera netta le differenze di opinione che dividono gli attivisti di partito e l’elettorato generale.
Fino alla settimana scorsa i candidati, sia repubblicani che democratici, erano concentrati esclusivamente sulla sfida con i propri compagni di partito e le loro strategie elettorali volte a convincere gli iscritti. Nelle ultime ore invece, con l’emergere di un gruppo ristretto di candidature credibili all’interno di entrambi i partiti (Clinton e Obama per l’asinello, Huckabee, Romney e McCain per l’elefante), l’attenzione ha cominciato a spostarsi sul voto di novembre, che sarà deciso dall’elettorato moderato. D’un tratto si è aperta, da entrambe le parti, la caccia al candidato che abbia le carte in regola non tanto per aggiudicarsi la nomination quanto per conquistare il cuore dell’americano medio e mediamente disinteressato alla politica. Si tratta del fattore eleggibilità, che d’ora in avanti dominerà ogni articolo di giornale, comizio elettorale e discorso da bar, e che molto probabilmente giocherà un ruolo decisivo nelle primarie delle prossime settimane.
John McCain pare stia conquistando il sostegno di una parte crescente della dirigenza del partito repubblicano, convinta che il senatore dell’Arizona sia l’unico ad avere una qualche speranza di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Tra gli ultimi successi di McCain, bisogna segnalare l’ufficializzazione dell’appoggio di una serie di illustri newyorkesi, tra i quali l’ex senatore Alfonse D’Amato, Henry Kissinger e Michael Finnegan che fu consigliere di George Pataki, ex-governatore dello stato (Patagi ancora non si è dichiarato). Con McCain rimangono in corsa Mitt Romney e Mike Huckabee, e l’incognita Rudy Giuliani, che sostiene di avere puntato tutto sul voto in Florida e di attendersi da questo Stato, famoso per le arance e gli immigrati cubani, una svolta decisiva in suo favore.
Il fatto che l’establishment del partito stia lentamente convergendo verso la candidatura di McCain non significa però che gli attivisti siano persuasi; tutt’altro. Chi tra loro ne ha la possibilità continua a fare campagna elettorale per il proprio favorito e visto che sono ancora solo gli iscritti ad avere il potere di determinare la nomination, non bisogna lasciarsi ingannare e credere che ormai l’esito sia scontato. Ne siano prova i sondaggi, che fino ad ora paiono aver capito poco delle primarie americane ma che almeno ne riconoscono l’incertezza. Nell’ultimo rilevamento di New York Times/CBS News condotto subito dopo le primarie del New Hampshire, il 72% dei repubblicani intervistati, e il 42% dei democratici, ha confessato di essere ancora indeciso su quale candidato scegliere.
Nel popolare blog repubblicano Townhall, Hugh Hewitt spiega ad esempio il proprio sostegno per Romney e Giuliani; “Ho in mente, nella scelta del candidato che vorrei veder nominato, l’instancabile fabbrica di attacchi personali che Hillary Clinton è capace di creare”. Nell’opinione di Hewitt il repubblicano prescelto dovrà essere in grado di scansare con ironia i colpi inflitti dalla ex first-lady e di ignorare quelle che lui chiama le “infinite macchinazioni di Clinton”. Hugh Hewitt è anche preoccupato della cronica mancanza di denaro della campagna di John McCain: “Un candidato forte non dovrebbe avere bisogno di girare per il paese con un piattino di latta in mano e supplicare gli attivisti per nuovi contributi solo pochi giorni prima di una primaria decisiva”, scrive. McCain è colpevole, secondo Townhall, di non essere stato capace di mettere assieme una macchina efficiente per la raccolta di fondi come, ad esempio, ha fatto Obama, con cui invece potrebbe competere Romney, se non altro grazie all’enorme ricchezza personale. Hewitt conclude la sua analisi in toni pessimistici: “Persino i fan di McCain devono ammettere che la sua candidatura è costruita su poco più che una doppia preghiera; il tentativo di convertire i conservatori americani al senatore dell’Arizona e quella di fargli aprire i portafogli. Purtroppo a causa delle dispute interne che li hanno visti divisi negli anni passati, i conservatori non si convertiranno alla
causa McCain, e anche se dovessero rassegnarsi alla sua candidatura, non contribuiranno economicamente alla campagna per le elezioni di novembre”.
Per ragioni differenti, ma altrettanto sentite, in un altro dei blog repubblicani più seguiti, Michelle Malkin attacca John McCain ed in particolare i suoi piani per combattere l’immigrazione. Mentre McCain si fa oggi paladino della lotta contro i clandestini ed ha assicurato il proprio appoggio per la costruzione di un vero e proprio muro che divida gli stati del sud, (California, Texas e Arizona) dal Messico, Malkin ricorda che l’anno scorso il senatore votò in favore di un’amnistia per alcune categorie di immigrati che si trovavano già da tempo sul suolo americano nonostante vi fossero arrivati illegalmente. “Come può McCain curare la sfiducia diffusa tra i cittadini se la sua stessa credibilità sulla questione è stata danneggiata fatalmente?” scrive Malkin. “Ci deve pur essere una ragione per cui tanti media e democratici di sinistra vedono positivamente la nomina di McCain per il partito repubblicano. McCain offre a costoro una buona copertura per continuare ad attaccare i veri conservatori di base”, Malkin conclude con rancore.
Che esista una frattura fra le dirigenze e la base del partito repubblicano non ci sono dubbi, così come è probabile che i media e l’elettorato moderato vedano di buon occhio una possibile vittoria di John McCain.
E’ invece opinabile l’idea che i liberal americani guardino con piacere alla nomination del senatore dell’Arizona. Piuttosto è vero il contrario; molti osservatori appartenenti alla sinistra del partito democratico paiono essere delusi e preoccupati di fronte al suo recente successo. Josh Marshall ha scritto di recente sul suo blog Talking Points Memo; “Speriamo che Mitt (Romney) vinca in Florida”. In fondo, John McCain è probabilmente il solo candidato di destra che possa vincere le presidenziali di novembre. Di conseguenza la sua vittoria nelle primarie repubblicane renderebbe le cose complicate allo sfidante democratico.
L’opinionista Walter Shapiro propone su Salon, un quotidiano di sinistra pubblicato esclusivamente sul web e considerato tra i più prestigiosi del paese, un’analisi interessante e al contempo divertente sulle varie possibili combinazioni di sfidanti alla Casa Bianca. L’intento è quello di determinare quale sia il migliore contendente democratico da opporre ai vari candidati repubblicani.
A John McCain, ragiona Shapiro, e ai suoi settantun’anni d’età, bisognerebbe opporre Obama, che con quarantasei è il più giovane tra tutti i candidati. McCain verrebbe così privato della possibilità di ricorrere incessantemente al suo passato di veterano del Vietnam e prigioniero di guerra. Obama del Vietnam ha solo qualche ricordo d’infanzia e dunque si parlerebbe d’altro. D’altro canto, il punto forza di McCain è proprio l’esperienza, che è anche la debolezza più evidente di Obama. Sarebbe forse meglio allora che fosse Clinton a battersi in un duello fra politici stagionati. Nel caso fosse Romney il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Shapiro e’ convinto che Clinton potrebbe competere alla pari quanto a perfezione robotica e immagine di ghiaccio. Però Obama potrebbe rispondere con successo al cinismo dell’ex-governatore del Massachusetts con il proprio messaggio di speranza. E via dicendo fin che Shapiro raggiunge una conclusione beffarda; “Questa campagna presidenziale si sta prendendo gioco del concetto sfuggente di eleggibilità come mai in passato. Gli elettori sia democratici che repubblicani sembrano essere estremamente confusi su quale tra i candidati del proprio partito sia il più eleggibile a livello nazionale”. Questo breve esercizio sottolinea, secondo Walter Shapiro, “la follia di chi tenta di decidere per chi votare sulla base di chi è considerato il candidato con le maggiori probabilità di successo nelle elezioni di novembre”.
Rimane, in sostanza, la grande contraddizione della politica presidenziale americana. Ovvero che le nomination di partito sono determinate dalla base degli attivisti, solitamente più radicali. Invece, per raggiungere il 51% occorre convincere la maggioranza silenziosa di elettori moderati che hanno ben poco a che spartire con gli iscritti di partito. La confusione che regna nei mesi che separano le primarie dalle elezioni nazionali offre agli americani la possibilità di confrontarsi e scontrarsi in maniera più libera di quanto il sistema bipartitico lascerebbe immaginare.
di Valentina Pasquali, Washington DC
La divisione tutta americana dell’elezione presidenziale in due tronconi, con le primarie di partito che aprono i giochi e le elezioni nazionali che li chiudono a quasi un anno di distanza, ha il pregio di portare alla luce la moltitudine di correnti di pensiero e di conflitti ideologici che esistono anche in questo paese, nonostante un sistema rigidamente bipartitico che limita e comprime il dibattito politico interno.
In questi giorni, i candidati democratici in corsa per la nomination del 2008 sono in Carolina del Sud, dove i membri del partito voteranno sabato 26 gennaio. I repubblicani, invece, stanno facendo campagna elettorale in Florida nell’attesa del voto del 29. La strada verso la Casa Bianca prosegue così rapidamente in direzione del Super Tuesday, il martedì 5 febbraio in cui ventiquattro stati dell’unione terranno le primarie contemporaneamente. E si sente nell’aria un desiderio crescente da parte degli elettori, ma soprattutto da parte dei media, di conoscere i nomi dei due candidati che si contenderanno la presidenza in novembre. Nello scambio sempre più intenso di pronostici si cominciano a delineare in maniera netta le differenze di opinione che dividono gli attivisti di partito e l’elettorato generale.
Fino alla settimana scorsa i candidati, sia repubblicani che democratici, erano concentrati esclusivamente sulla sfida con i propri compagni di partito e le loro strategie elettorali volte a convincere gli iscritti. Nelle ultime ore invece, con l’emergere di un gruppo ristretto di candidature credibili all’interno di entrambi i partiti (Clinton e Obama per l’asinello, Huckabee, Romney e McCain per l’elefante), l’attenzione ha cominciato a spostarsi sul voto di novembre, che sarà deciso dall’elettorato moderato. D’un tratto si è aperta, da entrambe le parti, la caccia al candidato che abbia le carte in regola non tanto per aggiudicarsi la nomination quanto per conquistare il cuore dell’americano medio e mediamente disinteressato alla politica. Si tratta del fattore eleggibilità, che d’ora in avanti dominerà ogni articolo di giornale, comizio elettorale e discorso da bar, e che molto probabilmente giocherà un ruolo decisivo nelle primarie delle prossime settimane.
John McCain pare stia conquistando il sostegno di una parte crescente della dirigenza del partito repubblicano, convinta che il senatore dell’Arizona sia l’unico ad avere una qualche speranza di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Tra gli ultimi successi di McCain, bisogna segnalare l’ufficializzazione dell’appoggio di una serie di illustri newyorkesi, tra i quali l’ex senatore Alfonse D’Amato, Henry Kissinger e Michael Finnegan che fu consigliere di George Pataki, ex-governatore dello stato (Patagi ancora non si è dichiarato). Con McCain rimangono in corsa Mitt Romney e Mike Huckabee, e l’incognita Rudy Giuliani, che sostiene di avere puntato tutto sul voto in Florida e di attendersi da questo Stato, famoso per le arance e gli immigrati cubani, una svolta decisiva in suo favore.
Il fatto che l’establishment del partito stia lentamente convergendo verso la candidatura di McCain non significa però che gli attivisti siano persuasi; tutt’altro. Chi tra loro ne ha la possibilità continua a fare campagna elettorale per il proprio favorito e visto che sono ancora solo gli iscritti ad avere il potere di determinare la nomination, non bisogna lasciarsi ingannare e credere che ormai l’esito sia scontato. Ne siano prova i sondaggi, che fino ad ora paiono aver capito poco delle primarie americane ma che almeno ne riconoscono l’incertezza. Nell’ultimo rilevamento di New York Times/CBS News condotto subito dopo le primarie del New Hampshire, il 72% dei repubblicani intervistati, e il 42% dei democratici, ha confessato di essere ancora indeciso su quale candidato scegliere.
Nel popolare blog repubblicano Townhall, Hugh Hewitt spiega ad esempio il proprio sostegno per Romney e Giuliani; “Ho in mente, nella scelta del candidato che vorrei veder nominato, l’instancabile fabbrica di attacchi personali che Hillary Clinton è capace di creare”. Nell’opinione di Hewitt il repubblicano prescelto dovrà essere in grado di scansare con ironia i colpi inflitti dalla ex first-lady e di ignorare quelle che lui chiama le “infinite macchinazioni di Clinton”. Hugh Hewitt è anche preoccupato della cronica mancanza di denaro della campagna di John McCain: “Un candidato forte non dovrebbe avere bisogno di girare per il paese con un piattino di latta in mano e supplicare gli attivisti per nuovi contributi solo pochi giorni prima di una primaria decisiva”, scrive. McCain è colpevole, secondo Townhall, di non essere stato capace di mettere assieme una macchina efficiente per la raccolta di fondi come, ad esempio, ha fatto Obama, con cui invece potrebbe competere Romney, se non altro grazie all’enorme ricchezza personale. Hewitt conclude la sua analisi in toni pessimistici: “Persino i fan di McCain devono ammettere che la sua candidatura è costruita su poco più che una doppia preghiera; il tentativo di convertire i conservatori americani al senatore dell’Arizona e quella di fargli aprire i portafogli. Purtroppo a causa delle dispute interne che li hanno visti divisi negli anni passati, i conservatori non si convertiranno alla
causa McCain, e anche se dovessero rassegnarsi alla sua candidatura, non contribuiranno economicamente alla campagna per le elezioni di novembre”.
Per ragioni differenti, ma altrettanto sentite, in un altro dei blog repubblicani più seguiti, Michelle Malkin attacca John McCain ed in particolare i suoi piani per combattere l’immigrazione. Mentre McCain si fa oggi paladino della lotta contro i clandestini ed ha assicurato il proprio appoggio per la costruzione di un vero e proprio muro che divida gli stati del sud, (California, Texas e Arizona) dal Messico, Malkin ricorda che l’anno scorso il senatore votò in favore di un’amnistia per alcune categorie di immigrati che si trovavano già da tempo sul suolo americano nonostante vi fossero arrivati illegalmente. “Come può McCain curare la sfiducia diffusa tra i cittadini se la sua stessa credibilità sulla questione è stata danneggiata fatalmente?” scrive Malkin. “Ci deve pur essere una ragione per cui tanti media e democratici di sinistra vedono positivamente la nomina di McCain per il partito repubblicano. McCain offre a costoro una buona copertura per continuare ad attaccare i veri conservatori di base”, Malkin conclude con rancore.
Che esista una frattura fra le dirigenze e la base del partito repubblicano non ci sono dubbi, così come è probabile che i media e l’elettorato moderato vedano di buon occhio una possibile vittoria di John McCain.
E’ invece opinabile l’idea che i liberal americani guardino con piacere alla nomination del senatore dell’Arizona. Piuttosto è vero il contrario; molti osservatori appartenenti alla sinistra del partito democratico paiono essere delusi e preoccupati di fronte al suo recente successo. Josh Marshall ha scritto di recente sul suo blog Talking Points Memo; “Speriamo che Mitt (Romney) vinca in Florida”. In fondo, John McCain è probabilmente il solo candidato di destra che possa vincere le presidenziali di novembre. Di conseguenza la sua vittoria nelle primarie repubblicane renderebbe le cose complicate allo sfidante democratico.
L’opinionista Walter Shapiro propone su Salon, un quotidiano di sinistra pubblicato esclusivamente sul web e considerato tra i più prestigiosi del paese, un’analisi interessante e al contempo divertente sulle varie possibili combinazioni di sfidanti alla Casa Bianca. L’intento è quello di determinare quale sia il migliore contendente democratico da opporre ai vari candidati repubblicani.
A John McCain, ragiona Shapiro, e ai suoi settantun’anni d’età, bisognerebbe opporre Obama, che con quarantasei è il più giovane tra tutti i candidati. McCain verrebbe così privato della possibilità di ricorrere incessantemente al suo passato di veterano del Vietnam e prigioniero di guerra. Obama del Vietnam ha solo qualche ricordo d’infanzia e dunque si parlerebbe d’altro. D’altro canto, il punto forza di McCain è proprio l’esperienza, che è anche la debolezza più evidente di Obama. Sarebbe forse meglio allora che fosse Clinton a battersi in un duello fra politici stagionati. Nel caso fosse Romney il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Shapiro e’ convinto che Clinton potrebbe competere alla pari quanto a perfezione robotica e immagine di ghiaccio. Però Obama potrebbe rispondere con successo al cinismo dell’ex-governatore del Massachusetts con il proprio messaggio di speranza. E via dicendo fin che Shapiro raggiunge una conclusione beffarda; “Questa campagna presidenziale si sta prendendo gioco del concetto sfuggente di eleggibilità come mai in passato. Gli elettori sia democratici che repubblicani sembrano essere estremamente confusi su quale tra i candidati del proprio partito sia il più eleggibile a livello nazionale”. Questo breve esercizio sottolinea, secondo Walter Shapiro, “la follia di chi tenta di decidere per chi votare sulla base di chi è considerato il candidato con le maggiori probabilità di successo nelle elezioni di novembre”.
Rimane, in sostanza, la grande contraddizione della politica presidenziale americana. Ovvero che le nomination di partito sono determinate dalla base degli attivisti, solitamente più radicali. Invece, per raggiungere il 51% occorre convincere la maggioranza silenziosa di elettori moderati che hanno ben poco a che spartire con gli iscritti di partito. La confusione che regna nei mesi che separano le primarie dalle elezioni nazionali offre agli americani la possibilità di confrontarsi e scontrarsi in maniera più libera di quanto il sistema bipartitico lascerebbe immaginare.
C'era una volta in America
(da: CFP NEWS - Anno 4 Numero 112 – 25 gennaio 2008)
Questa settimana ho scambiato almeno una dozzina di email con un amico della Columbia University a cui cercavo di spiegare cosa stesse succedendo nel triangolo delle Bermude "Signora Mastella-Ministro Mastella-Crisi di governo". Per quanto mi sia sforzato di essere chiaro e comprensibile, il mio collega palesemente faticava a capire la logica della politica
italiana. "Ma se c'è un'inchiesta sulla moglie, perché il marito si dimette?" era la sua domanda-chiave. Già, perché? Io avrei volentieri risposto che anche in Italia l'etica del servizio pubblico è così forte che il semplice sospetto di malaffare verso la moglie di Cesare (in questo caso, Clemente) era abbastanza per provocare le dimissioni da ministro di un uomo politico che vuole essere al di sopra di ogni sospetto.
Purtroppo, la risposta che ho dovuto dare era assai differente: al mio collega americano ho dovuto spiegare che Mastella si era prima dimesso, e poi era uscito dalla maggioranza, perché lamentava una insufficiente solidarietà da parte di Prodi CONTRO i giudici, una "debolezza" del
centrosinistra nel mettere il bavaglio alla magistratura.
Il mio amico ha risposto con un messaggio lapidario: "And what about SEPARATION-OF-POWERS?" ovvero: "Avete mai sentito parlare della separazione dei poteri?" Una volta rassicurato sul fatto che anche la ricca biblioteca del Senato contiene varie edizoni di Montesquieu, insisteva nel chiedermi com'era possibile che dei politici attaccassero i giudici per le loro inchieste, cosa che nemmeno Richard Nixon aveva osato fare. Non avendo risposta migliore, sono andato a cercare gli atti della convenzione costituzionale di Filadelfia dove, discutendo dell'impeachment, un delegato si spinse fino ad affermare che "se rieletto, il presidente sarebbe di per sé assolto da ogni accusa", intendendo che il giudizio POLITICO del popolo sovrano doveva avere la precedenza sul giudizio PENALE dei tribunali.
Il delegato si chiamava Gouverneur Morris ma, come il mio collega non ha mancato di farmi notare, la sua posizione rimase assolutamente isolata. L'impeachment entrò nella costituzione e l'idea di mettere i politici in qualche modo al di sopra della legge penale, o di renderli immuni dalle inchieste della magistratura, fu sepolta per sempre in quei giorni del settembre 1787. A questo punto, lo scambio epistolare, con mio grande sollievo, si è interrotto. Già, perché la soluzione americana ai possibili conflitti tra i diversi poteri dello Stato è una e una sola: sono i giudici ad avere l'ultima parola. Questo non solo sulle questioni di costituzionalità delle leggi (la Corte Suprema ha competenze e poteri assai più vasti e solidi della nostra Corte Costituzionale) ma soprattutto nel controllo sulla moralità pubblica, che esclude anche la sola ipotesi di una "immunità parlamentare" di qualche tipo.
Deputati e senatori sono oggetto di indagini, intercettazioni telefoniche e perfino arresti senza che nessuno abbia alcunché da obiettare. L'idea che questi poteri possano venire esercitati per ragioni partigiane o per colpire delle minoranze politiche è stata esclusa fino ad oggi dal senso
di responsabilità delle procure, sottoposte a uno stretto controllo da parte della stampa. Il fatto che esse siano nella maggioranza dei casi elettive, quindi soggette a subire le conseguenze politiche di iniziative imprudenti, rafforza il controllo su possibili abusi. Questo in tempi
recenti, naturalmente: nel 1920 il candidato socialista alla presidenza Eugene Debs era in cella, condannato per reati politici, e lì rimase fino al 1921, quando fu graziato.
Il caso più recente, dell'agosto 2007, è quello del senatore dell'Idaho Larry Craig arrestato per aver fatto delle avances a un poliziotto nelle toilette maschili dell'aereoporto di Minneapolis. L'Idaho è uno stato ultraconservatore, dove lo stesso Craig è stato eletto tre volte, l'ultima delle quali con il 65% dei voti ma né la legge, né considerazioni di "opportunità" hanno impedito di arrestarlo sul posto, processarlo nel giro di 24 ore e condannarlo sulla base del patteggiamento accettato dall'uomo politico.
Varie organizzazioni non governative tengono una precisa contabilità delle indagini su senatori, deputati e governatori: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington tiene addirittura una lista aggiornata dei 22 politici "più corrotti", fatta per l'87% di repubblicani (i democratici
sono soltanto 3). Negli ultimi due anni c'è stata un'ecatombe di
dimissioni fra i deputati vicini a Bush a causa dell'arresto e della condanna a sei anni di prigione del lobbista Jack Abramoff, i cui legami con il partito repubblicano erano ferrei. Il patteggiamento di Abramoff ha condotto alle dimissioni Tom DeLay, il capogruppo del partito alla Camera, e all'apertura di una serie di indagini giudiziarie che non si sono ancora
concluse. Uno dei motivi per cui DeLay è oggi un feroce oppositore della candidatura alla Presidenza di John McCain è che questi non difese i colleghi di partito quando scoppiò lo scandalo.
Risalendo nel tempo, troviamo il caso di William Janklow, un deputato ed ex governatore del South Dakota, che fu costretto alle dimissioni nel 2004, dopo essere stato condannato a tre mesi di carcere per omicidio colposo sulla strada. Apparentemente Janklow aveva (o era costretto ad avere) standard etici differenti da quelli del nostro "governatore" della Sicilia, che ha festeggiato a champagne e cannoli dopo essere stato condannato a 5 anni di galera per favoreggiamento di mafiosi d'alto rango.
Infine, nel 2001, troviamo il caso di James Traficant, espulso dalla Camera dopo essere stato condannato a 8 anni di prigione per corruzione. Anche in questo caso nessuno si prestò orecchio agli strilli del deputato democratico che gridava alla "persecuzione politica".
Per quanto interessa a noi, il punto chiave non è tanto la facilità con cui negli Stati Uniti la polizia indaga, i giudici valutano le prove e le giurie condannano, quanto il fatto che i giornali e la classe politica sono grosso modo unanimi nell'esigere le dimissioni di chi si fa cogliere
con le mani nel sacco. Il Congresso americano, in particolare negli anni di Bush jr., è diventato dal punto di vista etico una fogna (e non a caso sta in fondo alla lista delle istituzioni in cui i cittadini hanno fiducia) ma gli anticorpi ancora funzionano.
Al contrario, in Italia, non solo questo spirito "bipartisan" nell'esigere che i corrotti si facciano da parte non esiste ma l'ostilità nei confronti del controllo della magistratura sulle attività dei politici sta diventando, quella sì, un sentimento condiviso anche da parte del centrosinistra. Una deriva pericolosissima.
Questa settimana ho scambiato almeno una dozzina di email con un amico della Columbia University a cui cercavo di spiegare cosa stesse succedendo nel triangolo delle Bermude "Signora Mastella-Ministro Mastella-Crisi di governo". Per quanto mi sia sforzato di essere chiaro e comprensibile, il mio collega palesemente faticava a capire la logica della politica
italiana. "Ma se c'è un'inchiesta sulla moglie, perché il marito si dimette?" era la sua domanda-chiave. Già, perché? Io avrei volentieri risposto che anche in Italia l'etica del servizio pubblico è così forte che il semplice sospetto di malaffare verso la moglie di Cesare (in questo caso, Clemente) era abbastanza per provocare le dimissioni da ministro di un uomo politico che vuole essere al di sopra di ogni sospetto.
Purtroppo, la risposta che ho dovuto dare era assai differente: al mio collega americano ho dovuto spiegare che Mastella si era prima dimesso, e poi era uscito dalla maggioranza, perché lamentava una insufficiente solidarietà da parte di Prodi CONTRO i giudici, una "debolezza" del
centrosinistra nel mettere il bavaglio alla magistratura.
Il mio amico ha risposto con un messaggio lapidario: "And what about SEPARATION-OF-POWERS?" ovvero: "Avete mai sentito parlare della separazione dei poteri?" Una volta rassicurato sul fatto che anche la ricca biblioteca del Senato contiene varie edizoni di Montesquieu, insisteva nel chiedermi com'era possibile che dei politici attaccassero i giudici per le loro inchieste, cosa che nemmeno Richard Nixon aveva osato fare. Non avendo risposta migliore, sono andato a cercare gli atti della convenzione costituzionale di Filadelfia dove, discutendo dell'impeachment, un delegato si spinse fino ad affermare che "se rieletto, il presidente sarebbe di per sé assolto da ogni accusa", intendendo che il giudizio POLITICO del popolo sovrano doveva avere la precedenza sul giudizio PENALE dei tribunali.
Il delegato si chiamava Gouverneur Morris ma, come il mio collega non ha mancato di farmi notare, la sua posizione rimase assolutamente isolata. L'impeachment entrò nella costituzione e l'idea di mettere i politici in qualche modo al di sopra della legge penale, o di renderli immuni dalle inchieste della magistratura, fu sepolta per sempre in quei giorni del settembre 1787. A questo punto, lo scambio epistolare, con mio grande sollievo, si è interrotto. Già, perché la soluzione americana ai possibili conflitti tra i diversi poteri dello Stato è una e una sola: sono i giudici ad avere l'ultima parola. Questo non solo sulle questioni di costituzionalità delle leggi (la Corte Suprema ha competenze e poteri assai più vasti e solidi della nostra Corte Costituzionale) ma soprattutto nel controllo sulla moralità pubblica, che esclude anche la sola ipotesi di una "immunità parlamentare" di qualche tipo.
Deputati e senatori sono oggetto di indagini, intercettazioni telefoniche e perfino arresti senza che nessuno abbia alcunché da obiettare. L'idea che questi poteri possano venire esercitati per ragioni partigiane o per colpire delle minoranze politiche è stata esclusa fino ad oggi dal senso
di responsabilità delle procure, sottoposte a uno stretto controllo da parte della stampa. Il fatto che esse siano nella maggioranza dei casi elettive, quindi soggette a subire le conseguenze politiche di iniziative imprudenti, rafforza il controllo su possibili abusi. Questo in tempi
recenti, naturalmente: nel 1920 il candidato socialista alla presidenza Eugene Debs era in cella, condannato per reati politici, e lì rimase fino al 1921, quando fu graziato.
Il caso più recente, dell'agosto 2007, è quello del senatore dell'Idaho Larry Craig arrestato per aver fatto delle avances a un poliziotto nelle toilette maschili dell'aereoporto di Minneapolis. L'Idaho è uno stato ultraconservatore, dove lo stesso Craig è stato eletto tre volte, l'ultima delle quali con il 65% dei voti ma né la legge, né considerazioni di "opportunità" hanno impedito di arrestarlo sul posto, processarlo nel giro di 24 ore e condannarlo sulla base del patteggiamento accettato dall'uomo politico.
Varie organizzazioni non governative tengono una precisa contabilità delle indagini su senatori, deputati e governatori: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington tiene addirittura una lista aggiornata dei 22 politici "più corrotti", fatta per l'87% di repubblicani (i democratici
sono soltanto 3). Negli ultimi due anni c'è stata un'ecatombe di
dimissioni fra i deputati vicini a Bush a causa dell'arresto e della condanna a sei anni di prigione del lobbista Jack Abramoff, i cui legami con il partito repubblicano erano ferrei. Il patteggiamento di Abramoff ha condotto alle dimissioni Tom DeLay, il capogruppo del partito alla Camera, e all'apertura di una serie di indagini giudiziarie che non si sono ancora
concluse. Uno dei motivi per cui DeLay è oggi un feroce oppositore della candidatura alla Presidenza di John McCain è che questi non difese i colleghi di partito quando scoppiò lo scandalo.
Risalendo nel tempo, troviamo il caso di William Janklow, un deputato ed ex governatore del South Dakota, che fu costretto alle dimissioni nel 2004, dopo essere stato condannato a tre mesi di carcere per omicidio colposo sulla strada. Apparentemente Janklow aveva (o era costretto ad avere) standard etici differenti da quelli del nostro "governatore" della Sicilia, che ha festeggiato a champagne e cannoli dopo essere stato condannato a 5 anni di galera per favoreggiamento di mafiosi d'alto rango.
Infine, nel 2001, troviamo il caso di James Traficant, espulso dalla Camera dopo essere stato condannato a 8 anni di prigione per corruzione. Anche in questo caso nessuno si prestò orecchio agli strilli del deputato democratico che gridava alla "persecuzione politica".
Per quanto interessa a noi, il punto chiave non è tanto la facilità con cui negli Stati Uniti la polizia indaga, i giudici valutano le prove e le giurie condannano, quanto il fatto che i giornali e la classe politica sono grosso modo unanimi nell'esigere le dimissioni di chi si fa cogliere
con le mani nel sacco. Il Congresso americano, in particolare negli anni di Bush jr., è diventato dal punto di vista etico una fogna (e non a caso sta in fondo alla lista delle istituzioni in cui i cittadini hanno fiducia) ma gli anticorpi ancora funzionano.
Al contrario, in Italia, non solo questo spirito "bipartisan" nell'esigere che i corrotti si facciano da parte non esiste ma l'ostilità nei confronti del controllo della magistratura sulle attività dei politici sta diventando, quella sì, un sentimento condiviso anche da parte del centrosinistra. Una deriva pericolosissima.
lunedì 21 gennaio 2008
Hillary vs Obama - Dibattito South Carolina
Dibattito prima delle primarie della Carolina del Sud. Cresce la tensione tra i due candidati.
sabato 19 gennaio 2008
Yes, We Can
La canzone simbolo della campagna elettorale di Barack Obama.
Etichette:
VIDEO - Barack Obama,
VIDEO - Propaganda elettorale
venerdì 18 gennaio 2008
Primarie Democratiche: chi vincera' in Nevada?
(da: CFP NEWS - Anno 4 Numero 111 – 18 gennaio 2008)
di Valentina Pasquali, Washington DC
Circus Circus, Venetian e Treasure Island sono solo alcuni tra i nomi dei grandi hotel e casinó affacciati sullo Strip, un viale ampio, colata di cemento armato, che attraversa il cuore di Las Vegas, capitale americana del gioco d’azzardo e dello spogliarello. Milioni di turisti americani corrono qui ogni anno per giocarsi alle slot-machine gli spiccioli rimasti dopo aver acquistato l’assicurazione sanitaria privata, pagato la benzina per il monovolume e aver finanziato con le loro tasse una nuova iniezione di dollari nella guerra in Iraq. In quegli stessi stabilimenti turistici che si estendono per chilometri e si innalzano per decine di piani, centinaia di migliaia di camerieri, inservienti e addetti alle pulizie si alzano all’alba per rifare i letti e lavare i piatti nel tentativo di mettere assieme uno stipendio sufficiente ad arrivare alla fine del mese.
I carrozzoni elettorali di Hillary Clinton, Barack Obama e John Edwards sono parcheggiati in questo deserto del sudovest del paese già da alcuni giorni e lavorano incessantemente per conquistare il voto degli elettori locali. La competizione è talmente serrata che fare una previsione sull’esito delle primarie di sabato mattina è praticamente impossibile. Il giornalista Kirk Caraway, reporter del Nevada Appeal, un quotidiano con sede nella capitale dello stato Carson City, dice: “Nessun sondaggio riuscirà a predire il risultato di questa elezione; si può solo tirare ad indovinare.”
Innanzitutto, per la prima volta nella sua storia lo stato ha deciso di tenere dei caucus anziché un’elezione a scrutinio segreto. Di conseguenza tutti si domandano quale sarà la reazione dell’elettorato democratico alla nuova modalità di voto e in quale percentuale i membri del partito parteciperanno alla discussione. In secondo luogo, il Nevada ha deciso
quest’anno di anticipare la data di queste riunioni di partito all’inizio dell’anno. Tradizionalmente i residenti di questo stato votavano nella tarda primavera, quando in realtà la scelta era già stata determinata dal voto negli altri stati. Nel 2008, invece, i democratici del Nevada si riuniscono in un momento in cui la corsa è ancora aperta e quindi possono avere un impatto significativo sul proseguimento della campagna.
A questo si aggiunge l’incognita rappresentata dalla composizione demografica dello stato; “La popolazione del Nevada, per 9 degli ultimi 10 anni, ha avuto il tasso di crescita più alto del paese. Ciò significa che ci sono tanti elettori che non hanno radici qui. E’ un luogo caratterizzato da grande mobilità”, mi spiega Kirk Caraway. “In più i residenti di origine ispanica sono aumentati molto, un elemento che ancora non abbiamo visto in Iowa e New Hampshire”. Il U.S. Census Bureau, che pubblica le statistiche ufficiali sulla demografia degli Stati Uniti per il governo americano, riporta che nel 2006, quando fu condotto l’ultimo studio, gli ispano-americani costituivano il 24,4% dei cittadini del Nevada. La media nazionale e’ 14,8%.
Mentre si attende che i neri americani siano un fattore decisivo nelle primarie del 26 gennaio nella Carolina del Sud (secondo il U.S. Census Bureau nel 2006 gli afro-americani rappresentavano il 29% della popolazione dello stato contro il 12,8% a livello nazionale), gli elettori ispanici saranno probabilmente il fattore determinante in Nevada. Obama e Clinton hanno ingaggiato un duello serrato per cercare di ottenerne il sostegno. Entrambi hanno creato campagne pubblicitarie televisive e radiofoniche in spagnolo e impiegano un gran numero di lavoratori bilingui (Questo il piu' recente tra gli spot trasmessi da Obama in spagnolo). L’ex-first lady è, tra i vari contendenti, quella che coltiva da più tempo rapporti positivi con la comunità ispano-americana. Barack Obama cerca di competere portando all’attenzione, nei suoi comizi, la propria esperienza con problematiche importanti per questo gruppo etnico. “Se gli elettori d’origine ispanica guardano al mio passato, sono convinto che si convinceranno che, una volta eletto, sarò difensore appassionato del diritto all’eguaglianza e alla giustizia,” Obama ha dichiarato lunedì in un intervista con J. Patrick Coolican, reporter del Las Vegas Sun.
L’industria alberghiera è un’altra componente di importanza fondamentale. L’economia dello stato dipende direttamente dal giro d’affari mosso dal gioco d’azzardo, soprattutto a Las Vegas e Reno, con gli hotel, ristoranti, locali notturni e teatri che sono costruiti per ospitare i casinò ed attirare i turisti. Per questa ragione il Nevada è la patria di un esercito di lavoratori impiegati nell’industria dei servizi, e dei sindacati più potenti degli Stati Uniti.
Dopo il New Hampshire, e nonostante la vittoria di Hillary Clinton, due tra le principali organizzazioni di lavoratori hanno dichiarato il loro sostegno ufficiale per Barack Obama. La Culinary Workers Union rappresenta qui più di 60.000 lavoratori, mentre Service Employees International Union conta 17.500 membri sparsi per tutto lo stato. Nonostante questo, Hillary è venuta personalmente a bussare alle porte delle case di un quartiere, nel nordest di Las Vegas, abitato da un gran numero di appartenenti ai Culinary Workers. Il suo messaggio, nell’opinione di J. Patrick Coolan del Las Vegan Sun, è che “le dichiarazioni dei dirigenti non significano nulla e che i membri del Culinary dovrebbero seguire la propria coscienza individuale e non l’ordine del Segretario del sindacato”.
John Edwards, fanalino di coda nella corsa dopo le sconfitte in Iowa e New Hampshire, non ha ancora abbandonato i propri sogni presidenziali. Il New York Times riporta che lunedì David Bonior, il capo della campagna nazionale di Edwards, ha dichiarato ai giornalisti in una conferenza telefonica dal Nevada; “La corsa alla nomination è ancora aperta e questo è un ottimo segno per John Edwards che si avvicina con fiducia al voto in Nevada e South Carolina.”
Per un elettorato dall’alto tasso di mobilità e fatto d’immigrati e di lavoratori sotto-pagati, la risoluzione della guerra in Iraq non è vissuta qui come la priorità più impellente. Questi sono luoghi in cui la gente deve confrontarsi quotidianamente con le conseguenze di un’economia in crisi, ed e’ proprio il tema dell’economia che nell’ultima settimana ha assunto il ruolo centrale nelle campagne dei contendenti. Clinton, Edwards e Obama hanno presentato uno dopo l’altro i propri piani per il lancio di un pacchetto di aiuti economici diretto a coloro che sono stati colpiti più duramente dal problema dei mutui subprime. E l’economia e’ stata al centro del dibattito televisivo trasmesso martedì sera in diretta da Las Vegas dal network MSNBC, in cui i tre leader del partito democratico, dopo una settimana di schermaglie, hanno usato toni calmi per discutere dei loro programmi in dettaglio. Hillary Clinton ha persino dichiarato; “Siamo tutti parte di una grande famiglia, noi del partito democratico.”
Il quotidiano Reno Gazette-Journal ha condotto delle interviste telefoniche tra gli elettori democratici del Nevada tra l’11 e il 13 gennaio e i risultati del sondaggio mostrano una situazione molto incerta; Obama avrebbe il 32% delle preferenze, Clinton il 30%, e Edwards il 27%. Questi numeri sono all’interno del margine di errore statistico e quindi rendono impossibile delle previsioni accurate: bisognerà attendere i risultati reali che usciranno dai caucus sabato mattina per scoprire quale direzione prenderà la corsa democratica alla presidenza.
di Valentina Pasquali, Washington DC
Circus Circus, Venetian e Treasure Island sono solo alcuni tra i nomi dei grandi hotel e casinó affacciati sullo Strip, un viale ampio, colata di cemento armato, che attraversa il cuore di Las Vegas, capitale americana del gioco d’azzardo e dello spogliarello. Milioni di turisti americani corrono qui ogni anno per giocarsi alle slot-machine gli spiccioli rimasti dopo aver acquistato l’assicurazione sanitaria privata, pagato la benzina per il monovolume e aver finanziato con le loro tasse una nuova iniezione di dollari nella guerra in Iraq. In quegli stessi stabilimenti turistici che si estendono per chilometri e si innalzano per decine di piani, centinaia di migliaia di camerieri, inservienti e addetti alle pulizie si alzano all’alba per rifare i letti e lavare i piatti nel tentativo di mettere assieme uno stipendio sufficiente ad arrivare alla fine del mese.
I carrozzoni elettorali di Hillary Clinton, Barack Obama e John Edwards sono parcheggiati in questo deserto del sudovest del paese già da alcuni giorni e lavorano incessantemente per conquistare il voto degli elettori locali. La competizione è talmente serrata che fare una previsione sull’esito delle primarie di sabato mattina è praticamente impossibile. Il giornalista Kirk Caraway, reporter del Nevada Appeal, un quotidiano con sede nella capitale dello stato Carson City, dice: “Nessun sondaggio riuscirà a predire il risultato di questa elezione; si può solo tirare ad indovinare.”
Innanzitutto, per la prima volta nella sua storia lo stato ha deciso di tenere dei caucus anziché un’elezione a scrutinio segreto. Di conseguenza tutti si domandano quale sarà la reazione dell’elettorato democratico alla nuova modalità di voto e in quale percentuale i membri del partito parteciperanno alla discussione. In secondo luogo, il Nevada ha deciso
quest’anno di anticipare la data di queste riunioni di partito all’inizio dell’anno. Tradizionalmente i residenti di questo stato votavano nella tarda primavera, quando in realtà la scelta era già stata determinata dal voto negli altri stati. Nel 2008, invece, i democratici del Nevada si riuniscono in un momento in cui la corsa è ancora aperta e quindi possono avere un impatto significativo sul proseguimento della campagna.
A questo si aggiunge l’incognita rappresentata dalla composizione demografica dello stato; “La popolazione del Nevada, per 9 degli ultimi 10 anni, ha avuto il tasso di crescita più alto del paese. Ciò significa che ci sono tanti elettori che non hanno radici qui. E’ un luogo caratterizzato da grande mobilità”, mi spiega Kirk Caraway. “In più i residenti di origine ispanica sono aumentati molto, un elemento che ancora non abbiamo visto in Iowa e New Hampshire”. Il U.S. Census Bureau, che pubblica le statistiche ufficiali sulla demografia degli Stati Uniti per il governo americano, riporta che nel 2006, quando fu condotto l’ultimo studio, gli ispano-americani costituivano il 24,4% dei cittadini del Nevada. La media nazionale e’ 14,8%.
Mentre si attende che i neri americani siano un fattore decisivo nelle primarie del 26 gennaio nella Carolina del Sud (secondo il U.S. Census Bureau nel 2006 gli afro-americani rappresentavano il 29% della popolazione dello stato contro il 12,8% a livello nazionale), gli elettori ispanici saranno probabilmente il fattore determinante in Nevada. Obama e Clinton hanno ingaggiato un duello serrato per cercare di ottenerne il sostegno. Entrambi hanno creato campagne pubblicitarie televisive e radiofoniche in spagnolo e impiegano un gran numero di lavoratori bilingui (Questo il piu' recente tra gli spot trasmessi da Obama in spagnolo). L’ex-first lady è, tra i vari contendenti, quella che coltiva da più tempo rapporti positivi con la comunità ispano-americana. Barack Obama cerca di competere portando all’attenzione, nei suoi comizi, la propria esperienza con problematiche importanti per questo gruppo etnico. “Se gli elettori d’origine ispanica guardano al mio passato, sono convinto che si convinceranno che, una volta eletto, sarò difensore appassionato del diritto all’eguaglianza e alla giustizia,” Obama ha dichiarato lunedì in un intervista con J. Patrick Coolican, reporter del Las Vegas Sun.
L’industria alberghiera è un’altra componente di importanza fondamentale. L’economia dello stato dipende direttamente dal giro d’affari mosso dal gioco d’azzardo, soprattutto a Las Vegas e Reno, con gli hotel, ristoranti, locali notturni e teatri che sono costruiti per ospitare i casinò ed attirare i turisti. Per questa ragione il Nevada è la patria di un esercito di lavoratori impiegati nell’industria dei servizi, e dei sindacati più potenti degli Stati Uniti.
Dopo il New Hampshire, e nonostante la vittoria di Hillary Clinton, due tra le principali organizzazioni di lavoratori hanno dichiarato il loro sostegno ufficiale per Barack Obama. La Culinary Workers Union rappresenta qui più di 60.000 lavoratori, mentre Service Employees International Union conta 17.500 membri sparsi per tutto lo stato. Nonostante questo, Hillary è venuta personalmente a bussare alle porte delle case di un quartiere, nel nordest di Las Vegas, abitato da un gran numero di appartenenti ai Culinary Workers. Il suo messaggio, nell’opinione di J. Patrick Coolan del Las Vegan Sun, è che “le dichiarazioni dei dirigenti non significano nulla e che i membri del Culinary dovrebbero seguire la propria coscienza individuale e non l’ordine del Segretario del sindacato”.
John Edwards, fanalino di coda nella corsa dopo le sconfitte in Iowa e New Hampshire, non ha ancora abbandonato i propri sogni presidenziali. Il New York Times riporta che lunedì David Bonior, il capo della campagna nazionale di Edwards, ha dichiarato ai giornalisti in una conferenza telefonica dal Nevada; “La corsa alla nomination è ancora aperta e questo è un ottimo segno per John Edwards che si avvicina con fiducia al voto in Nevada e South Carolina.”
Per un elettorato dall’alto tasso di mobilità e fatto d’immigrati e di lavoratori sotto-pagati, la risoluzione della guerra in Iraq non è vissuta qui come la priorità più impellente. Questi sono luoghi in cui la gente deve confrontarsi quotidianamente con le conseguenze di un’economia in crisi, ed e’ proprio il tema dell’economia che nell’ultima settimana ha assunto il ruolo centrale nelle campagne dei contendenti. Clinton, Edwards e Obama hanno presentato uno dopo l’altro i propri piani per il lancio di un pacchetto di aiuti economici diretto a coloro che sono stati colpiti più duramente dal problema dei mutui subprime. E l’economia e’ stata al centro del dibattito televisivo trasmesso martedì sera in diretta da Las Vegas dal network MSNBC, in cui i tre leader del partito democratico, dopo una settimana di schermaglie, hanno usato toni calmi per discutere dei loro programmi in dettaglio. Hillary Clinton ha persino dichiarato; “Siamo tutti parte di una grande famiglia, noi del partito democratico.”
Il quotidiano Reno Gazette-Journal ha condotto delle interviste telefoniche tra gli elettori democratici del Nevada tra l’11 e il 13 gennaio e i risultati del sondaggio mostrano una situazione molto incerta; Obama avrebbe il 32% delle preferenze, Clinton il 30%, e Edwards il 27%. Questi numeri sono all’interno del margine di errore statistico e quindi rendono impossibile delle previsioni accurate: bisognerà attendere i risultati reali che usciranno dai caucus sabato mattina per scoprire quale direzione prenderà la corsa democratica alla presidenza.
Forse la lotta di classe non esiste più ma….
(da: CFP NEWS, anno 4 Numero 111 – 18 gennaio 2008)
La campagna di quest'anno per la presidenza avviene alla fine di un ciclo politico in cui la società americana è estremamente cambiata: tra il 1980 e il 2000, un periodo in cui i repubblicani hanno avuto successo nel ridurre le tasse per gli alti redditi anche quando il Congresso era controllato dai democratici, negli Stati Uniti la disuguaglianza economica è aumentata a livelli sconosciuti dopo la Grande Depressione. In questo arco di tempo, in dollari costanti, il reddito netto dello 0,1% degli americani più ricchi è passato dallo 0,5% del reddito nazionale al 3%, cioè si è moltiplicato per sei volte. Nel 1970, il reddito medio dei superricchi era «soltanto» 50 volte il reddito medio dell'insieme della popolazione, nel 2002, era diventato circa 300 volte. Il reddito dell'1% degli americani in cima alla scala dei redditi è passato dall'8% del reddito nazionale nel 1978 al 17% nel 1999, avvicinandosi allo storico record del 1928, quand'era attorno al 20%.
Due economisti specializzati nello studio della dinamica storica degli alti redditi hanno tratto la conclusione che "il declino nella progressività della tassa sul reddito fin dal 1980, la riduzione nelle aliquote delle tasse sui dividendi nel 2003 e la progettata cancellazione della tassa di successione nel 2011 potrebbero condurre di nuovo, entro pochi decenni, a livelli di concentrazione della ricchezza simili a quelli dell'inizio del XX secolo" (Piketty-Saez, di prossima pubblicazione).Forse la lotta di classe non esiste più ma ai miliardari americani non lo ha ancora detto nessuno.
La disuguaglianza sociale non poteva non ripercuotersi sulla disuguaglianza politica, perché la frazione più ricca della popolazione ha efficaci strumenti di lobby per difendere i propri interessi. Non solo: anche la partecipazione al voto non è distribuita omogeneamente tra le classi sociali. Mentre il 95% degli americani con un reddito superiore a 75.000 dollari vota (una percentuale superiore a quelle europee) meno del 50% di chi vive con un reddito inferiore a 15.000 dollari l'anno esprime il suo suffragio. Questo ha a che fare con le modalità tecniche del voto (registrazione volontaria e non automatica, voto in un giorno non festivo) che costituiscono barriere più faticose da superare per chi è povero o meno istruito. Resta il fatto che è soprattutto la sensazione di non poter influire sul processo politico che tiene lontani dalle urne gli americani di condizione modesta.
Benché i due partiti maggiori siano sempre stati in stretti rapporti con le élite economiche, storicamente i sindacati avevano un certo peso nel partito democratico. La loro quasi scomparsa ha lasciato un vuoto che le associazioni ecologiste o delle minoranze etniche non possono colmare. Non stupisce, quindi che a partire dalla metà degli anni Settanta si sia assistito a un sostanziale rafforzamento dell'influenza del denaro sulle campagne elettorali, influenza che quest'anno ha superato ogni precedente.
Nel 1992, la prima campagna presidenziale dei Clinton, il totale raccolto dai due partiti in vista delle elezioni ammontava a circa 620 milioni di dollari: una cifra enorme ma molto lontana da quella che sarebbe stata spesa solo 12 anni dopo. Per le elezioni del 2004 (Camera, Senato e presidenza) i due partiti hanno avuto a loro disposizione circa 1.450 milioni di dollari. In entrambi i casi, i repubblicani hanno goduto di finanziamenti superiori. Quest'anno, le previsioni sono di superare il miliardo di dollari per i soli candidati alla presidenza, senza calcolare quanto verrà raccolto dai 66 candidati a un seggio in Senato e dagli 870 candidati alla Camera, di cui quest'anno si parla ben poco. L'aumento delle spese è essenzialmente dovuto alla professionalizzazione delle campagne elettorali, sempre più condotte da esperti dei sondaggi, della pubblicità, dell'uso dei media, che vengono retribuiti a caro prezzo. Soprattutto, l'inesistenza di un settore televisivo pubblico fa sì che i candidati debbano comprare lo spazio per la loro pubblicità da emittenti commerciali che se lo fanno ben pagare. Nei principali media markets, per raggiungere una quota di popolazione significativa occorre spendere milioni di dollari.
Dal 2004, il Bipartisan Campaign Reform Act del 2002 ha raddoppiato i limiti del cosiddetto hard money, i contributi individuali a partiti e candidati (in precedenza non più di $1.000 l'anno) e invece vietato i contributi senza limiti ai partiti nazionali noti come soft money. Nel dicembre 2003, la Corte Suprema ha accettato questa impostazione. Da allora, molti sostenitori dei partiti che avevano usato come forma di finanziamento il soft money sono passati alle donazioni ai cosiddetti advocacy groups, cioè organizzazioni indipendenti che in teoria non dovrebbero essere legate ai partiti e che sono note nel gergo politico americano come «527» (dall'articolo del codice fiscale che definisce il loro status). I 527 sono diventati estremamente importanti: nel 2004 furono gli attacchi personali organizzati attraverso di loro a indebolire in modo fatale la candidatura di John Kerry.
Le campagne elettorali fino alla metà degli anni Settanta avevano un costo relativamente limitato, un ricorso alla televisione modesto e una raccolta fondi decentralizzata. Quest'ultimo era il fattore che maggiormente favoriva i candidati uscenti, che avevano già mostrato, durante il loro mandato, di essere degli alleati affidabili per le costituencies locali a cui chiedevano donazioni. Un senatore, o un deputato, si rivolgevano a finanziatori in massima parte locali, tanto più generosi quanto i politici erano in grado di mantenere le promesse, com'era il caso soprattutto dei potenti presidenti di commissione, sostanzialmente inamovibili grazie al sistema dell'anzianità e talvolta più potenti dello speaker della Camera o dello stesso Presidente. Solo fra il 2002 e il 2006, i candidati uscenti per un seggio del Senato hanno quasi raddoppiato le cifre raccolte (da 5,8 a 11,3 milioni di dollari), un ritmo che è stato tenuto anche dagli sfidanti (nel 2006 con 1,8 milioni raccolti in media) il che però significa che la voragine nella disponibilità di fondi fra i primi e i secondi è passata da 4,8 milioni nel 2002 a 9,5 milioni oggi. Le medie, inoltre, non danno un'immagine accurata di casi come quelli di Jon Corzine, un miliardario che nel 2000 decise di spendere 60 milioni di dollari della sua fortuna personale per diventare senatore del New Jersey sotto l'etichetta del partito democratico. Hillary Clinton nel 2006 ha raccolto, per la sua campagna al Senato, oltre 51 milioni di dollari (spendendone 41), di Rick Santorum, repubblicano della Pennsylvania (28,6 milioni) , di Joe Lieberman, ex democratico e ora indipendente del Connecticut (20,2 milioni).
Alla Camera, la situazione è simile: fra il 2002 e il 2006, i candidati uscenti per un seggio hanno aumentato di un terzo le cifre raccolte, un po' meno di quanto abbiano fatto gli sfidanti (+43%). Il gap nella disponibilità di fondi, tuttavia, rimane superiore a 4 contro 1. Alcune circoscrizioni, come la 13° e la 22° della Florida, hanno battuto tutti i record di spesa precedenti: nella prima il repubblicano Vernon Buchanan ha speso oltre 8 milioni di dollari contro i 3 del candidato democratico Christine Jennings (ha vinto il primo per soli 323 voti). Nella 22° circoscrizione, le dimissioni del deputato repubblicano uscente non hanno impedito al suo sostituto dell'ultima ora di spendere oltre 5 milioni di dollari, solo per essere sconfitto da uno sfidante democratico (anch'egli
ben finanziato) che ne ha spesi oltre 4. Quasi identica la dinamica nella circoscrizione n. 8 dell'Illinois, dove un democratico che ha raccolto 4 milioni di dollari è riuscito a prevalere su un repubblicano uscente che ne aveva a disposizione 5.
Per quanto interessa a noi in questa sede, l'esplosione dei costi della politica americana si manifesta chiaramente nelle somme raccolte dai candidati alla nomination fin qui: fino al 31 ottobre scorso, Hillary Clinton aveva raccolto circa 90 milioni di dollari, Barack Obama 80 e gli altri candidati insieme circa 70, cifre che sono enormemente aumentate nell'ultimo mese, cioè da quando la campagna elettorale è entrata nel vivo.
Quest'anno, i candidati repubblicani sembrano sorprendentemente in difficoltà: alla stessa data Romney aveva raccolto solo 63 milioni, Giuliani 47 e McCain 32. Quest'ultimo, ancora un mese fa, era dato per "fuori gioco" dai commentatori non tanto per il merito delle sue posizioni politiche e per la sua credibilità come candidato ma semplicemente per il fatto che non era più in grado di pagare i collaboratori. La sua vittoria nelle primarie del New Hampshire gli ha dato una boccata d'ossigeno nella raccolta fondi ma, per avere delle chances di successo, dovrà raccogliere rapidamente le cifre necessarie a pagare la propaganda elettorale nei 47 stati dove non si è ancora votato.
Complessivamente, il significato di questa competizione per la raccolta fondi è molto semplce: i candidati possono adottare una retorica populista (e quest'anno lo fanno anche più volentieri del solito) ma ciò che non possono fare è scontentare i grandi donatori. L'unico che, fino ad oggi, ha dimostrato una certa capacità di raccogliere piccole somme via internet è Barack Obama ma per conquistare la nomination e poi restare in corsa fino alla fine per la presidenza la ricetta è una sola: ogni mattina occorre raccogliere 2 milioni di dollari, 1,3 milioni di euro, e bisogna farlo prima di sera.
La campagna di quest'anno per la presidenza avviene alla fine di un ciclo politico in cui la società americana è estremamente cambiata: tra il 1980 e il 2000, un periodo in cui i repubblicani hanno avuto successo nel ridurre le tasse per gli alti redditi anche quando il Congresso era controllato dai democratici, negli Stati Uniti la disuguaglianza economica è aumentata a livelli sconosciuti dopo la Grande Depressione. In questo arco di tempo, in dollari costanti, il reddito netto dello 0,1% degli americani più ricchi è passato dallo 0,5% del reddito nazionale al 3%, cioè si è moltiplicato per sei volte. Nel 1970, il reddito medio dei superricchi era «soltanto» 50 volte il reddito medio dell'insieme della popolazione, nel 2002, era diventato circa 300 volte. Il reddito dell'1% degli americani in cima alla scala dei redditi è passato dall'8% del reddito nazionale nel 1978 al 17% nel 1999, avvicinandosi allo storico record del 1928, quand'era attorno al 20%.
Due economisti specializzati nello studio della dinamica storica degli alti redditi hanno tratto la conclusione che "il declino nella progressività della tassa sul reddito fin dal 1980, la riduzione nelle aliquote delle tasse sui dividendi nel 2003 e la progettata cancellazione della tassa di successione nel 2011 potrebbero condurre di nuovo, entro pochi decenni, a livelli di concentrazione della ricchezza simili a quelli dell'inizio del XX secolo" (Piketty-Saez, di prossima pubblicazione).Forse la lotta di classe non esiste più ma ai miliardari americani non lo ha ancora detto nessuno.
La disuguaglianza sociale non poteva non ripercuotersi sulla disuguaglianza politica, perché la frazione più ricca della popolazione ha efficaci strumenti di lobby per difendere i propri interessi. Non solo: anche la partecipazione al voto non è distribuita omogeneamente tra le classi sociali. Mentre il 95% degli americani con un reddito superiore a 75.000 dollari vota (una percentuale superiore a quelle europee) meno del 50% di chi vive con un reddito inferiore a 15.000 dollari l'anno esprime il suo suffragio. Questo ha a che fare con le modalità tecniche del voto (registrazione volontaria e non automatica, voto in un giorno non festivo) che costituiscono barriere più faticose da superare per chi è povero o meno istruito. Resta il fatto che è soprattutto la sensazione di non poter influire sul processo politico che tiene lontani dalle urne gli americani di condizione modesta.
Benché i due partiti maggiori siano sempre stati in stretti rapporti con le élite economiche, storicamente i sindacati avevano un certo peso nel partito democratico. La loro quasi scomparsa ha lasciato un vuoto che le associazioni ecologiste o delle minoranze etniche non possono colmare. Non stupisce, quindi che a partire dalla metà degli anni Settanta si sia assistito a un sostanziale rafforzamento dell'influenza del denaro sulle campagne elettorali, influenza che quest'anno ha superato ogni precedente.
Nel 1992, la prima campagna presidenziale dei Clinton, il totale raccolto dai due partiti in vista delle elezioni ammontava a circa 620 milioni di dollari: una cifra enorme ma molto lontana da quella che sarebbe stata spesa solo 12 anni dopo. Per le elezioni del 2004 (Camera, Senato e presidenza) i due partiti hanno avuto a loro disposizione circa 1.450 milioni di dollari. In entrambi i casi, i repubblicani hanno goduto di finanziamenti superiori. Quest'anno, le previsioni sono di superare il miliardo di dollari per i soli candidati alla presidenza, senza calcolare quanto verrà raccolto dai 66 candidati a un seggio in Senato e dagli 870 candidati alla Camera, di cui quest'anno si parla ben poco. L'aumento delle spese è essenzialmente dovuto alla professionalizzazione delle campagne elettorali, sempre più condotte da esperti dei sondaggi, della pubblicità, dell'uso dei media, che vengono retribuiti a caro prezzo. Soprattutto, l'inesistenza di un settore televisivo pubblico fa sì che i candidati debbano comprare lo spazio per la loro pubblicità da emittenti commerciali che se lo fanno ben pagare. Nei principali media markets, per raggiungere una quota di popolazione significativa occorre spendere milioni di dollari.
Dal 2004, il Bipartisan Campaign Reform Act del 2002 ha raddoppiato i limiti del cosiddetto hard money, i contributi individuali a partiti e candidati (in precedenza non più di $1.000 l'anno) e invece vietato i contributi senza limiti ai partiti nazionali noti come soft money. Nel dicembre 2003, la Corte Suprema ha accettato questa impostazione. Da allora, molti sostenitori dei partiti che avevano usato come forma di finanziamento il soft money sono passati alle donazioni ai cosiddetti advocacy groups, cioè organizzazioni indipendenti che in teoria non dovrebbero essere legate ai partiti e che sono note nel gergo politico americano come «527» (dall'articolo del codice fiscale che definisce il loro status). I 527 sono diventati estremamente importanti: nel 2004 furono gli attacchi personali organizzati attraverso di loro a indebolire in modo fatale la candidatura di John Kerry.
Le campagne elettorali fino alla metà degli anni Settanta avevano un costo relativamente limitato, un ricorso alla televisione modesto e una raccolta fondi decentralizzata. Quest'ultimo era il fattore che maggiormente favoriva i candidati uscenti, che avevano già mostrato, durante il loro mandato, di essere degli alleati affidabili per le costituencies locali a cui chiedevano donazioni. Un senatore, o un deputato, si rivolgevano a finanziatori in massima parte locali, tanto più generosi quanto i politici erano in grado di mantenere le promesse, com'era il caso soprattutto dei potenti presidenti di commissione, sostanzialmente inamovibili grazie al sistema dell'anzianità e talvolta più potenti dello speaker della Camera o dello stesso Presidente. Solo fra il 2002 e il 2006, i candidati uscenti per un seggio del Senato hanno quasi raddoppiato le cifre raccolte (da 5,8 a 11,3 milioni di dollari), un ritmo che è stato tenuto anche dagli sfidanti (nel 2006 con 1,8 milioni raccolti in media) il che però significa che la voragine nella disponibilità di fondi fra i primi e i secondi è passata da 4,8 milioni nel 2002 a 9,5 milioni oggi. Le medie, inoltre, non danno un'immagine accurata di casi come quelli di Jon Corzine, un miliardario che nel 2000 decise di spendere 60 milioni di dollari della sua fortuna personale per diventare senatore del New Jersey sotto l'etichetta del partito democratico. Hillary Clinton nel 2006 ha raccolto, per la sua campagna al Senato, oltre 51 milioni di dollari (spendendone 41), di Rick Santorum, repubblicano della Pennsylvania (28,6 milioni) , di Joe Lieberman, ex democratico e ora indipendente del Connecticut (20,2 milioni).
Alla Camera, la situazione è simile: fra il 2002 e il 2006, i candidati uscenti per un seggio hanno aumentato di un terzo le cifre raccolte, un po' meno di quanto abbiano fatto gli sfidanti (+43%). Il gap nella disponibilità di fondi, tuttavia, rimane superiore a 4 contro 1. Alcune circoscrizioni, come la 13° e la 22° della Florida, hanno battuto tutti i record di spesa precedenti: nella prima il repubblicano Vernon Buchanan ha speso oltre 8 milioni di dollari contro i 3 del candidato democratico Christine Jennings (ha vinto il primo per soli 323 voti). Nella 22° circoscrizione, le dimissioni del deputato repubblicano uscente non hanno impedito al suo sostituto dell'ultima ora di spendere oltre 5 milioni di dollari, solo per essere sconfitto da uno sfidante democratico (anch'egli
ben finanziato) che ne ha spesi oltre 4. Quasi identica la dinamica nella circoscrizione n. 8 dell'Illinois, dove un democratico che ha raccolto 4 milioni di dollari è riuscito a prevalere su un repubblicano uscente che ne aveva a disposizione 5.
Per quanto interessa a noi in questa sede, l'esplosione dei costi della politica americana si manifesta chiaramente nelle somme raccolte dai candidati alla nomination fin qui: fino al 31 ottobre scorso, Hillary Clinton aveva raccolto circa 90 milioni di dollari, Barack Obama 80 e gli altri candidati insieme circa 70, cifre che sono enormemente aumentate nell'ultimo mese, cioè da quando la campagna elettorale è entrata nel vivo.
Quest'anno, i candidati repubblicani sembrano sorprendentemente in difficoltà: alla stessa data Romney aveva raccolto solo 63 milioni, Giuliani 47 e McCain 32. Quest'ultimo, ancora un mese fa, era dato per "fuori gioco" dai commentatori non tanto per il merito delle sue posizioni politiche e per la sua credibilità come candidato ma semplicemente per il fatto che non era più in grado di pagare i collaboratori. La sua vittoria nelle primarie del New Hampshire gli ha dato una boccata d'ossigeno nella raccolta fondi ma, per avere delle chances di successo, dovrà raccogliere rapidamente le cifre necessarie a pagare la propaganda elettorale nei 47 stati dove non si è ancora votato.
Complessivamente, il significato di questa competizione per la raccolta fondi è molto semplce: i candidati possono adottare una retorica populista (e quest'anno lo fanno anche più volentieri del solito) ma ciò che non possono fare è scontentare i grandi donatori. L'unico che, fino ad oggi, ha dimostrato una certa capacità di raccogliere piccole somme via internet è Barack Obama ma per conquistare la nomination e poi restare in corsa fino alla fine per la presidenza la ricetta è una sola: ogni mattina occorre raccogliere 2 milioni di dollari, 1,3 milioni di euro, e bisogna farlo prima di sera.
lunedì 14 gennaio 2008
Barack Obama e i sindacalisti del Culinary Workers vanno porta a porta in Nevada
Dal sito ufficial di Barack Obama
sabato 12 gennaio 2008
venerdì 11 gennaio 2008
Primarie Democratiche: la lunga sfida Obama-Clinton
(da: CFP NEWS - Anno 4 Numero 110 – 11 gennaio 2008)
di Valentina Pasquali, Washington DC
La vittoria di Hillary Clinton nelle primarie in New Hampshire riapre la corsa alla nomination dopo che gli osservatori davano per scontata l’affermazione di Barack Obama lanciato dal trionfo in Iowa. Intanto la carovana elettorale è diretta verso il Nevada, dove il 19 gennaio si terranno i prossimi caucus, le riunioni di partito in cui gli iscritti sceglieranno il vincitore della nomination per lo stato.
In New Hampshire i sondaggisti hanno fallito gli exit-poll sottostimando la popolarità di Clinton. La figura imbarazzante è attribuibile all’ondata d’entusiasmo pro-Obama che ha travolto i media dopo il voto in Iowa. Gli esperti hanno perso il contatto con il territorio, mentre i sostenitori di Clinton continuavano ad inondare di telefonate le abitazioni degli indecisi in New Hampshire.
Il risultato è girato grazie al voto femminile. Le donne dell’Iowa avevano scelto di sostenere Obama (35% contro il 30% di Clinton). In New Hampshire la senatrice di New York ha riconquistato la fiducia di uno degli zoccoli duri del suo elettorato (47% contro il 34% di Obama). Nell’ultima settimana l’ex-first lady ha proiettato con successo un’immagine diversa da quella di donna gelida. In un incontro con gli elettori lunedì, Clinton si è lasciata trasportare dalla commozione e ha mostrato occhi lucidi. Esibendo i propri sentimenti Hillary è riuscita a ristabilire un contatto personale con le elettrici.
I toni a tratti offensivi assunti da tanti nel parlare di Clinton dopo l’Iowa hanno contribuito a provocare la reazione dell’elettorato democratico. In Daily Kos, uno dei blog politici di sinistra più letti, Markos Moulitsas scrive; “Più Clinton viene attaccata a livello personale, più la sua personalità e’ destinata a generare simpatia e comprensione, e maggiore il numero di voti che riceverà.”
Questa constatazione suggerisce un desiderio generale di moderazione dei toni, invece la discussione si fa più acre. In un’intervista al network televisivo MSNBC mercoledì, Jesse Jackson Jr., uno dei consiglieri di Obama, ha accusato Clinton di essere capace di lacrime solo nei momenti di difficoltà personale e di rimanere indifferente ad istanti di vero dramma nazionale, come ad esempio l’uragano Katrina che devastò le coste della Luisiana nel 2005. Todd Beeton offre la sua interpretazione su MyDD, un altro popolare blog politico; “Jackson ha fatto riferimenti ripetuti a Katrina. E così cerca di dire agli afro-americani, che furono allora i più toccati, che a Hillary non importa delle persone di colore”. La campagna di Obama si prepara in questo modo alla Carolina del Sud, dove il 26 gennaio si terrà un’altra tornata elettorale che si prevede sarà decisa dagli elettori neri.
Il sistema di voto delle primarie democratiche potrebbe incoraggiare ulteriormente l’uso di strategie aggressive. Esiste, infatti, la possibilità reale che la corsa alla nomination rimanga incerta fino alla convention di Denver del 25 agosto e che i candidati prolunghino le lotte intestine fino all’estate.
Nelle primarie, gli iscritti votano per i candidati e il voto è tradotto in un numero di delegati che partecipano alle convention con l’incarico di stabilire la nomina del partito secondo il mandato popolare. Le primarie democratiche adottano un sistema proporzionale che attribuisce delegati in rapporto alle percentuali di voto. Così, ad esempio, il 39% di Clinton in New Hampshire ed il 37% di Obama hanno significato nove delegati per entrambi.
Tale sistema potrebbe favorire i repubblicani. Il partito dell’elefante, segue regole diverse. Su Slate, un quotidiano on-line di tendenza liberal, Michelle Tsai spiega; “Visto che molti stati adottano un sistema maggioritario in cui il vincitore ottiene tutti i delegati dello stato, i candidati repubblicani accumulano delegati più velocemente dei democratici. Questo significa che la nomination repubblicana emergerà probabilmente in anticipo”.
Se così fosse, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, liberatosi più presto della competizione interna al partito, potrà dedicare tempo denaro alla campagna nazionale e avvantaggiarsi dei veleni che, nel frattempo, i democratici continueranno a scambiarsi.
Per quanto riguarda Obama, un dato interessante emerge dal voto degli elettori indipendenti. Il New Hampshire è il solo stato che consente a costoro di partecipare alle primarie. Il senatore dell’Illinois è stato il prescelto di questo gruppo vincendo il voto di sei sui 10. Da un lato questa è un’indicazione della sua eleggibilità nelle elezioni generali di novembre. Dall’altro Obama dovrà arrivare alla nomination senza il loro sostegno dato che gli indipendenti non prenderanno parte a nessun’altra primaria.
Buone notizie per il senatore dell’Illinois arrivano dai sindacati. Già martedì sera la Service Employees International Union, che in Nevada rappresenta 17.500 impiegati dei servizi pubblici come infermiere o guardie notturne, aveva ufficialmente dichiarato il proprio appoggio per Obama. Il sindacato dei lavoratori dell’industria alberghiera, Culinary Workers Union, che nello stato del gioco d’azzardo conta 60.000 iscritti, ha ufficializzato la medesima scelta in una conferenza stampa mercoledì mattina.
Rimane infine John Edwards, a cui il New Hampshire ha riservato solo il 17% dei voti. Gli esperti parlano di un suo possibile ritiro. Edwards non molla e nel discorso fatto martedì sera ha promesso che lotterà fino alla convention di agosto. Per lui sarà fondamentale il voto del 26 nella Carolina del Sud, dove è nato e che vinse durante le primarie del 2004. Un sondaggio Rasmussen di lunedì vede Obama vincitore con il 42% dei voti, seconda Clinton con il 30%, e nuovamente terzo Edwards con solo il 14%. Se queste previsioni verranno confermate, la lotta si trasformerà davvero in un semplice duello Clinton-Obama.
di Valentina Pasquali, Washington DC
La vittoria di Hillary Clinton nelle primarie in New Hampshire riapre la corsa alla nomination dopo che gli osservatori davano per scontata l’affermazione di Barack Obama lanciato dal trionfo in Iowa. Intanto la carovana elettorale è diretta verso il Nevada, dove il 19 gennaio si terranno i prossimi caucus, le riunioni di partito in cui gli iscritti sceglieranno il vincitore della nomination per lo stato.
In New Hampshire i sondaggisti hanno fallito gli exit-poll sottostimando la popolarità di Clinton. La figura imbarazzante è attribuibile all’ondata d’entusiasmo pro-Obama che ha travolto i media dopo il voto in Iowa. Gli esperti hanno perso il contatto con il territorio, mentre i sostenitori di Clinton continuavano ad inondare di telefonate le abitazioni degli indecisi in New Hampshire.
Il risultato è girato grazie al voto femminile. Le donne dell’Iowa avevano scelto di sostenere Obama (35% contro il 30% di Clinton). In New Hampshire la senatrice di New York ha riconquistato la fiducia di uno degli zoccoli duri del suo elettorato (47% contro il 34% di Obama). Nell’ultima settimana l’ex-first lady ha proiettato con successo un’immagine diversa da quella di donna gelida. In un incontro con gli elettori lunedì, Clinton si è lasciata trasportare dalla commozione e ha mostrato occhi lucidi. Esibendo i propri sentimenti Hillary è riuscita a ristabilire un contatto personale con le elettrici.
I toni a tratti offensivi assunti da tanti nel parlare di Clinton dopo l’Iowa hanno contribuito a provocare la reazione dell’elettorato democratico. In Daily Kos, uno dei blog politici di sinistra più letti, Markos Moulitsas scrive; “Più Clinton viene attaccata a livello personale, più la sua personalità e’ destinata a generare simpatia e comprensione, e maggiore il numero di voti che riceverà.”
Questa constatazione suggerisce un desiderio generale di moderazione dei toni, invece la discussione si fa più acre. In un’intervista al network televisivo MSNBC mercoledì, Jesse Jackson Jr., uno dei consiglieri di Obama, ha accusato Clinton di essere capace di lacrime solo nei momenti di difficoltà personale e di rimanere indifferente ad istanti di vero dramma nazionale, come ad esempio l’uragano Katrina che devastò le coste della Luisiana nel 2005. Todd Beeton offre la sua interpretazione su MyDD, un altro popolare blog politico; “Jackson ha fatto riferimenti ripetuti a Katrina. E così cerca di dire agli afro-americani, che furono allora i più toccati, che a Hillary non importa delle persone di colore”. La campagna di Obama si prepara in questo modo alla Carolina del Sud, dove il 26 gennaio si terrà un’altra tornata elettorale che si prevede sarà decisa dagli elettori neri.
Il sistema di voto delle primarie democratiche potrebbe incoraggiare ulteriormente l’uso di strategie aggressive. Esiste, infatti, la possibilità reale che la corsa alla nomination rimanga incerta fino alla convention di Denver del 25 agosto e che i candidati prolunghino le lotte intestine fino all’estate.
Nelle primarie, gli iscritti votano per i candidati e il voto è tradotto in un numero di delegati che partecipano alle convention con l’incarico di stabilire la nomina del partito secondo il mandato popolare. Le primarie democratiche adottano un sistema proporzionale che attribuisce delegati in rapporto alle percentuali di voto. Così, ad esempio, il 39% di Clinton in New Hampshire ed il 37% di Obama hanno significato nove delegati per entrambi.
Tale sistema potrebbe favorire i repubblicani. Il partito dell’elefante, segue regole diverse. Su Slate, un quotidiano on-line di tendenza liberal, Michelle Tsai spiega; “Visto che molti stati adottano un sistema maggioritario in cui il vincitore ottiene tutti i delegati dello stato, i candidati repubblicani accumulano delegati più velocemente dei democratici. Questo significa che la nomination repubblicana emergerà probabilmente in anticipo”.
Se così fosse, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, liberatosi più presto della competizione interna al partito, potrà dedicare tempo denaro alla campagna nazionale e avvantaggiarsi dei veleni che, nel frattempo, i democratici continueranno a scambiarsi.
Per quanto riguarda Obama, un dato interessante emerge dal voto degli elettori indipendenti. Il New Hampshire è il solo stato che consente a costoro di partecipare alle primarie. Il senatore dell’Illinois è stato il prescelto di questo gruppo vincendo il voto di sei sui 10. Da un lato questa è un’indicazione della sua eleggibilità nelle elezioni generali di novembre. Dall’altro Obama dovrà arrivare alla nomination senza il loro sostegno dato che gli indipendenti non prenderanno parte a nessun’altra primaria.
Buone notizie per il senatore dell’Illinois arrivano dai sindacati. Già martedì sera la Service Employees International Union, che in Nevada rappresenta 17.500 impiegati dei servizi pubblici come infermiere o guardie notturne, aveva ufficialmente dichiarato il proprio appoggio per Obama. Il sindacato dei lavoratori dell’industria alberghiera, Culinary Workers Union, che nello stato del gioco d’azzardo conta 60.000 iscritti, ha ufficializzato la medesima scelta in una conferenza stampa mercoledì mattina.
Rimane infine John Edwards, a cui il New Hampshire ha riservato solo il 17% dei voti. Gli esperti parlano di un suo possibile ritiro. Edwards non molla e nel discorso fatto martedì sera ha promesso che lotterà fino alla convention di agosto. Per lui sarà fondamentale il voto del 26 nella Carolina del Sud, dove è nato e che vinse durante le primarie del 2004. Un sondaggio Rasmussen di lunedì vede Obama vincitore con il 42% dei voti, seconda Clinton con il 30%, e nuovamente terzo Edwards con solo il 14%. Se queste previsioni verranno confermate, la lotta si trasformerà davvero in un semplice duello Clinton-Obama.
Elezioni americane: istruzioni per l’uso
(da CFP NEWS, Anno 4 Numero 110 – 11 gennaio 2008)
Tempo di elezioni primarie negli Stati Uniti e il chiacchericcio giornalistico si concentra sui candidati, sulle loro debolezze, i loro punti di forza, le loro strategie. A determinare la politica americana, in realtà, sono meccanismi istituzionali e politici assai mal compresi, a cominciare da quello del collegio elettorale (un’ottima mappa con anche le date in cui si tengono le primarie qui: http://www.electoral-vote.com/). Al contrario di quanto molti credono, negli Stati Uniti le presidenziali sono un’elezione di secondo grado, cioè un’elezione da parte di un apposito organo e non un’elezione diretta da parte dei cittadini. Questi votano, Stato per Stato, per liste con un certo numero di delegati, i quali si riuniscono in dicembre, oltre un mese dopo il voto popolare, ed è in questa sede che il Presidente viene eletto a maggioranza.
Tutto si basa sul compromesso in sede di convenzione costituzionale a Filadelfia, nel 1787: per convincere i piccoli stati a ratificare la Costituzione e ad accettare un governo centralizzato, fu loro garantita una uguale rappresentanza in Senato: due senatori per il minuscolo Delaware e due per la grande Pennsylvania, due senatori per il sottopopolato Rhode Island e due per il gigantesco New York. Oltre a ciò, si decise che il voto per il Presidente sarebbe avvenuto in un collegio ad hoc, composto di tanti rappresentanti di ciascuno Stato quanti erano i deputati e i senatori di quello Stato insieme. Questo assicura una certa proporzionalità fra composizione demografica e numero di delegati nel collegio elettorale, ma al prezzo di sovrarappresentare fortemente gli Stati più piccoli.
Per esempio, circa 23 milioni di abitanti sparsi tra l’Alaska e il Golfo del Messico eleggono ben 61 grandi elettori, più dei 54 elettori della California, che conta 35 milioni di abitanti, e una volta e mezzo più di New York e Massachusetts, che insieme hanno 25,4 milioni di abitanti ma devono accontentarsi di 43 grandi elettori.
Al contrario, il Massachusetts con 6,4 milioni di abitanti ha 12 grandi elettori e New York, con 19 milioni, ne ha
31: pertanto 25,4 milioni di cittadini di questi due stati dispongono soltanto di 43 voti nel collegio elettorale.
Le mappe colorate che i giornali pubblicano dopo ogni tornata elettorale per l’elezione del Presidente mostrano un continente dominato dai repubblicani (tutto il Sud e l’Ovest degli Stati Uniti, fino alle Montagne Rocciose) con alcune roccaforti democratiche sulle due coste e nel Midwest. Come si sa, nel 2000 Al Gore ebbe 539.898 voti popolari in più di George W. Bush, ma fu ugualmente sconfitto nel collegio elettorale (ipotizziamo che i risultati della Florida fossero regolari[1]) perché i repubblicani traggono enorme vantaggio dal loro dominio negli Stati rurali e poco popolati delle grandi praterie e delle Montagne Rocciose. Nel 2000, Bush ottenne tutti i voti dei grandi elettori (che all’epoca erano 59) negli stati del midwest poco popolato, mentre due soli stati con una popolazione simile, nei quali prevalse Gore, con circa 5,7 milioni di elettori, produssero 45 voti elettorali. Bush, con 5,2 milioni di voti, ottenne 59 voti elettorali, un vantaggio di 14 voti elettorali, assai superiore a quello con cui il candidato repubblicano “vinse” (271 voti elettorali contro 267 a Gore).
La situazione è peggiorata nelle elezioni del 2004, in cui circa cinque milioni di elettori repubblicani negli Stati già citati hanno ottenuto 61 grandi elettori per il loro candidato alla Casa Bianca, mentre circa sei milioni di elettori democratici hanno fornito al loro candidato John Kerry soltanto 45 grandi elettori, ben 16 di meno.
Sarà utile, a questo punto, esaminare storicamente l’ascesa del Sud nel collegio elettorale.
Mettiamo a confronto due blocchi regionali in termini di rappresentanza all’interno del collegio elettorale che elegge il Presidente: gli 11 stati dell’ex Confederazione e i tre stati-chiave del Nordest, New York, Connecticut e Massachusetts.
Come si vede, il Sud ha mantenuto a lungo una posizione abbastanza stabile all’interno del collegio elettorale: tra il 1932 e il 1972, la sua rappresentanza oscillava tra il 23,3 e il 24,2%. Dopo il 1972, in coincidenza con lo storico rovesciamento di affiliazione partitica che gettava questi 11 stati nelle braccia dei repubblicani, iniziava anche uno spostamento economico e demografico di grande ampiezza. Tra il 1972 e il 2000, la popolazione degli Stati del Sud è cresciuta molto più del resto della nazione, con milioni di nuovi cittadini che hanno preso la residenza in Texas, Florida, Georgia, Nord Carolina. Questo processo ha avuto importanti conseguenze politiche, perché i 435 seggi della Camera dei rappresentanti vengono redistribuiti tra gli Stati ogni dieci anni e la delegazione di ciascun Stato nel collegio elettorale è composta da un numero uguale alla somma di deputati e senatori.
Oggi, il blocco sudista ha guadagnato ulteriori posizioni, raggiungendo i 153 voti, ovvero il 28,4% del collegio elettorale. Non c’è da stupirsi che, nel dicembre 2002, Trent Lott, il leader della maggioranza repubblicana in Senato, avesse rivendicato esplicitamente l’eredità della segregazione razziale in occasione del 100° compleanno del senatore Strom Thurmond, il quale nel 1948 si presentò alle presidenziali su una piattaforma apertamente razzista (poi Lott fu costretto alle dimissioni, ma la strategia repubblicana non è cambiata).
Se confrontiamo il Sud con New York, Connecticut e Massachusetts, scopriamo che questi due stati controllavano nel 1932 circa il 13,6% dei voti necessari per eleggere il Presidente, più della metà di quelli dell’ex Confederazione. La proporzione è scesa lentamente per ragioni demografiche e, nelle prossimo novembre, i 153 voti del Sud rappresenteranno esattamente il triplo dei voti degli yankee. Questo aiuta a comprendere anche il motivo per cui l’ultimo presidente democratico proveniente dal Massachusetts sia stato John Kennedy (1960) e l’ultimo originario di New York sia stato Franklin Roosevelt (1932-1944). Non si tratta certo di un buon auspicio per Hillary Rodham Clinton, senatrice di New York.
Nelle ultime otto elezioni presidenziali, i candidati democratici sono stati Gore (Tennessee), Clinton (Arkansas), Dukakis e Kerry (Massachusetts), Mondale (Minnesota), Carter (Georgia). Solo i sudisti Clinton e Carter hanno vinto, mentre Mondale (1984), Dukakis (1988) e Kerry (2004) hanno subito sconfitte senza appello. Insieme, i due blocchi di stati del Sud e dell’Ovest che ormai votano regolarmente repubblicano controllano 214 voti elettorali, il 40% del collegio, il che significa che bastano altri 57 voti, da raggranellare negli stati del midwest o della costa atlantica, per entrare alla Casa Bianca. Se aggiungiamo i 12 voti elettorali dell’Indiana e gli 11 di Kansas e Nebraska (che non hanno più votato per un candidato democratico dopo Lyndon Johnson) si arriva a 237 voti “sicuri” per il candidato repubblicano, chiunque esso sia.
I repubblicani dispongono quindi dell’88% dei voti che servono per eleggere il Presidente, più o meno in qualunque circostanza, chiunque sia il loro candidato e qualunque sia l’orientamento maggioritario dell’opinione pubblica.
Questo, naturalmente, non significa che i giochi siano fatti: al contrario. Nel 2008 si vedranno con maggiore chiarezza le fratture nel blocco sociale repubblicano già apparse nelle elezioni per il Congresso del novembre 2006. E’ possibile, per esempio, che il Colorado passi ai democratici, che potrebbero vincere anche in Iowa e New Mexico, dove nel 2004 ha prevalso George W. Bush per poche migliaia di voti. E’ però importante capire che la strada, per il candidato democratico alla presidenza, chiunque egli sia, sarà tutta in salita.
[1] Per un’analisi di come la vittoria fu rubata si veda il mio libro Il nazionalismo americano, UTET 2007, pp. 122-130. http://www.utetuniversita.it/scheda_opera.asp?DAPAG=HOME&ID_OPERA=3202.
[2] Dopo il censimento del 2000, i voti elettorali dell’Arizona sono diventati 10, quelli del Colorado 9, quelli dell’Oklahoma 7, quindi il totale (ai fini delle elezioni del 2008) è 61 e non più 59.
[3] Dopo il censimento del 2000, i voti elettorali di New York sono 31 e non più 33, quindi il totale oggi è 43 e non più 45.
Tempo di elezioni primarie negli Stati Uniti e il chiacchericcio giornalistico si concentra sui candidati, sulle loro debolezze, i loro punti di forza, le loro strategie. A determinare la politica americana, in realtà, sono meccanismi istituzionali e politici assai mal compresi, a cominciare da quello del collegio elettorale (un’ottima mappa con anche le date in cui si tengono le primarie qui: http://www.electoral-vote.com/). Al contrario di quanto molti credono, negli Stati Uniti le presidenziali sono un’elezione di secondo grado, cioè un’elezione da parte di un apposito organo e non un’elezione diretta da parte dei cittadini. Questi votano, Stato per Stato, per liste con un certo numero di delegati, i quali si riuniscono in dicembre, oltre un mese dopo il voto popolare, ed è in questa sede che il Presidente viene eletto a maggioranza.
Tutto si basa sul compromesso in sede di convenzione costituzionale a Filadelfia, nel 1787: per convincere i piccoli stati a ratificare la Costituzione e ad accettare un governo centralizzato, fu loro garantita una uguale rappresentanza in Senato: due senatori per il minuscolo Delaware e due per la grande Pennsylvania, due senatori per il sottopopolato Rhode Island e due per il gigantesco New York. Oltre a ciò, si decise che il voto per il Presidente sarebbe avvenuto in un collegio ad hoc, composto di tanti rappresentanti di ciascuno Stato quanti erano i deputati e i senatori di quello Stato insieme. Questo assicura una certa proporzionalità fra composizione demografica e numero di delegati nel collegio elettorale, ma al prezzo di sovrarappresentare fortemente gli Stati più piccoli.
Per esempio, circa 23 milioni di abitanti sparsi tra l’Alaska e il Golfo del Messico eleggono ben 61 grandi elettori, più dei 54 elettori della California, che conta 35 milioni di abitanti, e una volta e mezzo più di New York e Massachusetts, che insieme hanno 25,4 milioni di abitanti ma devono accontentarsi di 43 grandi elettori.
Al contrario, il Massachusetts con 6,4 milioni di abitanti ha 12 grandi elettori e New York, con 19 milioni, ne ha
31: pertanto 25,4 milioni di cittadini di questi due stati dispongono soltanto di 43 voti nel collegio elettorale.
Le mappe colorate che i giornali pubblicano dopo ogni tornata elettorale per l’elezione del Presidente mostrano un continente dominato dai repubblicani (tutto il Sud e l’Ovest degli Stati Uniti, fino alle Montagne Rocciose) con alcune roccaforti democratiche sulle due coste e nel Midwest. Come si sa, nel 2000 Al Gore ebbe 539.898 voti popolari in più di George W. Bush, ma fu ugualmente sconfitto nel collegio elettorale (ipotizziamo che i risultati della Florida fossero regolari[1]) perché i repubblicani traggono enorme vantaggio dal loro dominio negli Stati rurali e poco popolati delle grandi praterie e delle Montagne Rocciose. Nel 2000, Bush ottenne tutti i voti dei grandi elettori (che all’epoca erano 59) negli stati del midwest poco popolato, mentre due soli stati con una popolazione simile, nei quali prevalse Gore, con circa 5,7 milioni di elettori, produssero 45 voti elettorali. Bush, con 5,2 milioni di voti, ottenne 59 voti elettorali, un vantaggio di 14 voti elettorali, assai superiore a quello con cui il candidato repubblicano “vinse” (271 voti elettorali contro 267 a Gore).
La situazione è peggiorata nelle elezioni del 2004, in cui circa cinque milioni di elettori repubblicani negli Stati già citati hanno ottenuto 61 grandi elettori per il loro candidato alla Casa Bianca, mentre circa sei milioni di elettori democratici hanno fornito al loro candidato John Kerry soltanto 45 grandi elettori, ben 16 di meno.
Sarà utile, a questo punto, esaminare storicamente l’ascesa del Sud nel collegio elettorale.
Mettiamo a confronto due blocchi regionali in termini di rappresentanza all’interno del collegio elettorale che elegge il Presidente: gli 11 stati dell’ex Confederazione e i tre stati-chiave del Nordest, New York, Connecticut e Massachusetts.
Come si vede, il Sud ha mantenuto a lungo una posizione abbastanza stabile all’interno del collegio elettorale: tra il 1932 e il 1972, la sua rappresentanza oscillava tra il 23,3 e il 24,2%. Dopo il 1972, in coincidenza con lo storico rovesciamento di affiliazione partitica che gettava questi 11 stati nelle braccia dei repubblicani, iniziava anche uno spostamento economico e demografico di grande ampiezza. Tra il 1972 e il 2000, la popolazione degli Stati del Sud è cresciuta molto più del resto della nazione, con milioni di nuovi cittadini che hanno preso la residenza in Texas, Florida, Georgia, Nord Carolina. Questo processo ha avuto importanti conseguenze politiche, perché i 435 seggi della Camera dei rappresentanti vengono redistribuiti tra gli Stati ogni dieci anni e la delegazione di ciascun Stato nel collegio elettorale è composta da un numero uguale alla somma di deputati e senatori.
Oggi, il blocco sudista ha guadagnato ulteriori posizioni, raggiungendo i 153 voti, ovvero il 28,4% del collegio elettorale. Non c’è da stupirsi che, nel dicembre 2002, Trent Lott, il leader della maggioranza repubblicana in Senato, avesse rivendicato esplicitamente l’eredità della segregazione razziale in occasione del 100° compleanno del senatore Strom Thurmond, il quale nel 1948 si presentò alle presidenziali su una piattaforma apertamente razzista (poi Lott fu costretto alle dimissioni, ma la strategia repubblicana non è cambiata).
Se confrontiamo il Sud con New York, Connecticut e Massachusetts, scopriamo che questi due stati controllavano nel 1932 circa il 13,6% dei voti necessari per eleggere il Presidente, più della metà di quelli dell’ex Confederazione. La proporzione è scesa lentamente per ragioni demografiche e, nelle prossimo novembre, i 153 voti del Sud rappresenteranno esattamente il triplo dei voti degli yankee. Questo aiuta a comprendere anche il motivo per cui l’ultimo presidente democratico proveniente dal Massachusetts sia stato John Kennedy (1960) e l’ultimo originario di New York sia stato Franklin Roosevelt (1932-1944). Non si tratta certo di un buon auspicio per Hillary Rodham Clinton, senatrice di New York.
Nelle ultime otto elezioni presidenziali, i candidati democratici sono stati Gore (Tennessee), Clinton (Arkansas), Dukakis e Kerry (Massachusetts), Mondale (Minnesota), Carter (Georgia). Solo i sudisti Clinton e Carter hanno vinto, mentre Mondale (1984), Dukakis (1988) e Kerry (2004) hanno subito sconfitte senza appello. Insieme, i due blocchi di stati del Sud e dell’Ovest che ormai votano regolarmente repubblicano controllano 214 voti elettorali, il 40% del collegio, il che significa che bastano altri 57 voti, da raggranellare negli stati del midwest o della costa atlantica, per entrare alla Casa Bianca. Se aggiungiamo i 12 voti elettorali dell’Indiana e gli 11 di Kansas e Nebraska (che non hanno più votato per un candidato democratico dopo Lyndon Johnson) si arriva a 237 voti “sicuri” per il candidato repubblicano, chiunque esso sia.
I repubblicani dispongono quindi dell’88% dei voti che servono per eleggere il Presidente, più o meno in qualunque circostanza, chiunque sia il loro candidato e qualunque sia l’orientamento maggioritario dell’opinione pubblica.
Questo, naturalmente, non significa che i giochi siano fatti: al contrario. Nel 2008 si vedranno con maggiore chiarezza le fratture nel blocco sociale repubblicano già apparse nelle elezioni per il Congresso del novembre 2006. E’ possibile, per esempio, che il Colorado passi ai democratici, che potrebbero vincere anche in Iowa e New Mexico, dove nel 2004 ha prevalso George W. Bush per poche migliaia di voti. E’ però importante capire che la strada, per il candidato democratico alla presidenza, chiunque egli sia, sarà tutta in salita.
[1] Per un’analisi di come la vittoria fu rubata si veda il mio libro Il nazionalismo americano, UTET 2007, pp. 122-130. http://www.utetuniversita.it/scheda_opera.asp?DAPAG=HOME&ID_OPERA=3202.
[2] Dopo il censimento del 2000, i voti elettorali dell’Arizona sono diventati 10, quelli del Colorado 9, quelli dell’Oklahoma 7, quindi il totale (ai fini delle elezioni del 2008) è 61 e non più 59.
[3] Dopo il censimento del 2000, i voti elettorali di New York sono 31 e non più 33, quindi il totale oggi è 43 e non più 45.
mercoledì 9 gennaio 2008
Il discorso della vittoria in New Hampshire
La prima "resurrezione" di Hillary. Sconfitta nello Iowa, ribalta tutti i sondaggi e si afferma nel New Hampshire.
lunedì 7 gennaio 2008
La commozione di Hillary
Alla vigilia delle primarie in New Hampshire, Hillary parla con voce rotta dall'emozione. Secondo alcuni osservatori, la sua commozione è stata decisiva nel coinvolgere e ricompattare a suo favore l'elettorato femminile.
sabato 5 gennaio 2008
venerdì 4 gennaio 2008
martedì 1 gennaio 2008
Iscriviti a:
Post (Atom)